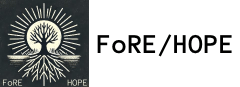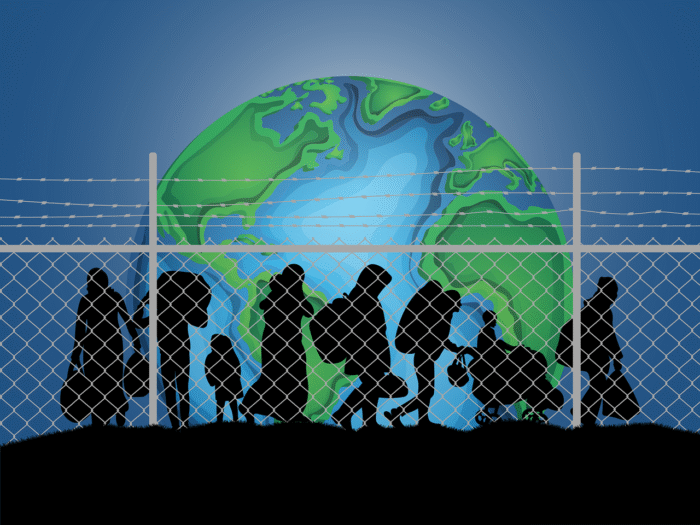Riflessioni di un collaboratore al progetto “Forme di resistenza e pratiche di speranza”
Prince Duah Agyei
Il 17 settembre 2025, durante una pausa pranzo con alcuni colleghi, mi sono ritrovato coinvolto in una conversazione che mi è rimasta impressa. Seduti attorno al tavolo, abbiamo parlato di come la violenza continui a influenzare la mobilità umana, spesso in modo subdolo e mascherata dal linguaggio delle opportunità. Abbiamo notato che la schiavitù moderna persiste sotto le spoglie di promesse di lavoro, allettanti prospettive di una vita migliore o illusorie opportunità all’estero. La discussione è stata illuminante. La migrazione non è mai solo una questione di spostamento, ma comporta anche rischi di sfruttamento, esclusione e precarietà. Eppure, anche quando le persone sono a conoscenza di tutti i fatti, quando conoscono i pericoli, le promesse non mantenute, le incertezze, la solitudine e la possibilità di rimanere intrappolate in un circolo vizioso di sfruttamento, continuano a scegliere di partire. Questa consapevolezza ha suscitato in me una domanda fondamentale: perché le persone migrano davvero?
È una domanda che resiste a risposte semplici. Lasciare la propria casa, attraversare i confini ed entrare nell’ignoto non è solo un calcolo economico. È un atto animato dalla speranza, dalla speranza di trasformazione, di rinnovamento e di qualcosa di più di ciò che è disponibile a casa. Allo stesso tempo, tali viaggi sono una forma di resistenza contro condizioni invivibili, contro il peso soffocante della disuguaglianza sistemica e contro la preclusione delle possibilità. La migrazione, quindi, incarna sia la speranza che la resistenza: è audace di fronte al rischio e creativa di fronte alla disperazione. Questa vignetta cattura in miniatura le preoccupazioni più ampie del progetto Forms of Resistance & Practices of Hope (Forme di resistenza e pratiche di speranza), all’interno del quale i miei contributi accademici hanno cercato di esplorare proprio questa interrelazione tra i migranti dell’Africa occidentale (migranti africani). Oltre a condurre conversazioni etnografiche e generare dati, nonché a contribuire alla progettazione e all’insegnamento del corso Intersections of Peace, Resistance and Hope (Intersezioni di pace, resistenza e speranza) presso l’Università di Tampere, il mio coinvolgimento di un anno nel progetto ha portato alla produzione di due articoli, entrambi attualmente in diverse fasi di revisione.
Il primo articolo (scritto in collaborazione con Angel Iglesias Ortiz), Resistance and Hope in Balance: Toward a Complementary Conceptual Framework, nasce dalla consapevolezza che il rapporto tra resistenza e speranza è stato troppo spesso trascurato dal punto di vista teorico. La resistenza è spesso concettualizzata come un’azione di opposizione diretta contro il dominio, mentre la speranza è trattata come un orientamento astratto e aspirazionale verso il futuro. Ciò che mancava era un’esplorazione della loro complementarità. Attingendo a casi provenienti dall’Africa, dall’Asia e dal Nord America, abbiamo sostenuto che gli atti quotidiani di sfida, sia che si tratti di esaurire tutte le vie legali contro l’espulsione, di riunirsi ai confini per contestare la separazione o di rifiutare di accettare sentenze ingiuste, non sono semplici gesti di sopravvivenza, ma sono sostenuti dalla speranza. Al contrario, la speranza stessa diventa politica e tangibile solo quando viene messa in atto attraverso tali pratiche quotidiane di resistenza. In questo modo, l’articolo ha cercato di colmare il divario concettuale tra due discorsi potenti ma spesso scollegati, dimostrando che la speranza e la resistenza insieme aprono nuove possibilità di cambiamento sociale e politico.
Il secondo articolo, Hope, Resistance, and the Migrant Condition (Speranza, resistenza e condizione dei migranti), ha approfondito questo lavoro concettuale basandolo su una ricerca etnografica condotta su migranti dell’Africa occidentale in Finlandia. In questo caso, le narrazioni dei partecipanti hanno rivelato i modi fragili ma resilienti in cui la speranza e la resistenza si intrecciano nella vita quotidiana. I migranti hanno attinto alla speranza non solo come motivazione iniziale per trasferirsi, perseguire l’istruzione, opportunità economiche o la vita familiare, ma anche come forza sostenitrice quando si sono trovati ad affrontare esclusione, discriminazione o ostacoli burocratici. La loro resistenza ha assunto molte forme: presentazione di petizioni al parlamento, ricorso contro decisioni legali, coinvolgimento dei media per cambiare il discorso pubblico, perseveranza nel lavoro accademico nonostante le barriere istituzionali e, in alcuni casi, adozione dell’inazione strategica come strategia di sopravvivenza. Questi atti erano raramente spettacolari o collettivi, ma erano profondamente politici nel modo in cui preservavano la possibilità di futuri alternativi. In queste esperienze vissute, la speranza e la resistenza sono emerse non come domini separati, ma come forze che si costituiscono a vicenda.
Guardando indietro, vedo la conversazione durante il pranzo del 17 settembre come un punto di ingresso simbolico alle domande che ho perseguito durante tutto il progetto. Mi ha ricordato che anche quando i rischi sono evidenti e i pericoli innegabili, le persone osano comunque migrare. Questa audacia non è riducibile a ingenuità o disperazione. È una politica di speranza in azione. Migrare in questo modo significa rifiutare i limiti imposti dal luogo, dalle circostanze o dall’esclusione. Significa resistere all’essere confinati in un presente ritenuto invivibile e affermare che un’altra vita è possibile, anche se incerta.
Questa riflessione rafforza ciò che ho capito attraverso questo progetto: che la resistenza e la speranza sono compagne necessarie, sia nella vita di coloro che si spostano, sia nel lavoro di coloro che li studiano. Per me, la ricerca stessa è diventata una pratica di resistenza speranzosa, un’insistenza nel riconoscere l’azione delle voci emarginate, nel teorizzare le loro lotte quotidiane come significative e nel rifiutare la cancellazione della violenza sistemica. I miei due articoli rappresentano un modesto contributo a questo più ampio sforzo: tentativi di teorizzare l’interazione tra resistenza e speranza e di documentare come questa interazione plasmi la vita dei migranti nell’Europa di oggi.
Alla fine, il mio coinvolgimento nel progetto non è stato solo un esercizio accademico, ma uno spazio di apprendimento profondo. Mi ha mostrato che impegnarsi criticamente con la resistenza e la speranza significa impegnarsi con le condizioni stesse della perseveranza umana nell’incertezza. Significa riconoscere che, mentre la violenza e l’esclusione persistono, così fanno anche le pratiche quotidiane attraverso le quali le persone resistono e immaginano un’alternativa. E, cosa forse più importante, mi ha ricordato che anche noi, come studiosi, dobbiamo incarnare la resistenza e la speranza, resistendo alla disperazione all’interno delle nostre istituzioni e aggrappandoci alla speranza che il nostro lavoro possa illuminare, per quanto modestamente, i percorsi verso un futuro più giusto. Quando ripenso a quel pranzo del 17 settembre, mi rendo conto che la domanda che ci siamo posti allora è ancora attuale: perché le persone migrano davvero? Le conversazioni, gli scritti e le riflessioni condivise di questo progetto suggeriscono una risposta. Le persone migrano perché, anche di fronte al pericolo e alla delusione, osano sperare e, nell’osare, resistono.